6.3 Concorrenza sui prezzi
Nel modello di Cournot le imprese devono decidere quante unità produrre prima che il prezzo si formi. In molti mercati, però, la capacità produttiva può essere rapidamente adattata alla domanda di mercato, e la variabile strategica diventa il prezzo. È il caso, ad esempio, dei servizi di telefonia mobile e connettività internet, dove è possibile servire nuovi clienti istantaneamente. Lo stesso vale per le piattaforme di streaming, che possono accogliere nuovi utenti senza limiti fisici immediati.
Paradosso di Bertrand
Il duopolio di Bertrand rappresenta Il paradosso porta il nome del matematico Joseph Bertrand, che nel 1883 criticò l’ipotesi di Cournot secondo cui le imprese competono sulle quantità, sostenendo invece che la vera concorrenza è sul prezzo. un contesto di questo tipo come un gioco a mosse simultanee tra due imprese che offrono un bene omogeneo. Ciascuna impresa annuncia un prezzo unitario a cui vendere il bene o servizio; i consumatori acquistano dal venditore con il prezzo più basso o, in caso di parità, si dividono tra le due imprese. Come illustriamo nella figura seguente — dove assumiamo domanda di mercato $Q=5000-1000P$ e costo marginale $MC=2$ uguale per le due imprese — questo meccanismo conduce a un esito sorprendente: l’equilibrio coincide con quello della concorrenza perfetta.
Diversi meccanismi permettono di superare il paradosso e spiegare perché, in realtà, nei mercati oligopolistici i prezzi sono superiori al costo marginale, e i profitti delle imprese sono positivi. Tra questi meccanismi troviamo i vincoli di capacità, la differenziazione dei prodotti e l’interazione ripetuta nel tempo.
Vincoli di capacità
Il paradosso
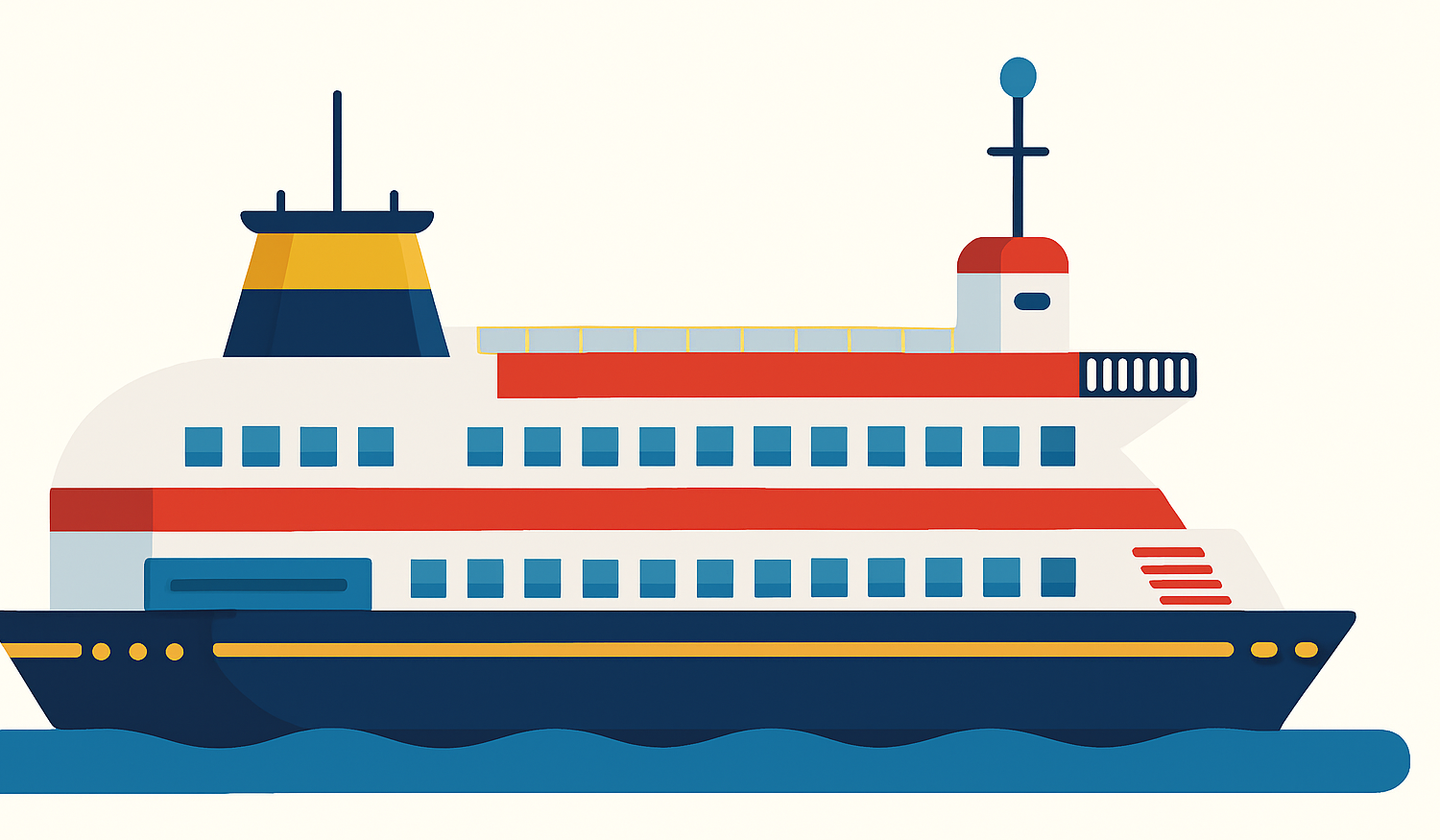 Le compagnie aeree, così come quelle di navigazione, si fanno concorrenza sul prezzo, ma non possono vendere oltre la capacità dei loro posti.
di Bertrand presuppone che ogni impresa possa soddisfare tutta la domanda di mercato al prezzo più basso. Ciò non è realistico: in alcuni mercati le imprese possono produrre quantità virtualmente illimitate, ma in tanti altri esistono limiti alla capacità produttiva. In presenza di tali vincoli, se un’impresa abbassa il prezzo, non può comunque accaparrarsi l’intero mercato. Questo riduce l’incentivo a farsi la guerra sui prezzi, poiché i benefici di un prezzo più basso sono limitati dalla capacità disponibile. Di conseguenza, in equilibrio le imprese mantengono prezzi superiori al costo marginale, ottenendo profitti positivi. L’esito di equilibrio si avvicina allora a quello del modello di Cournot.
Le compagnie aeree, così come quelle di navigazione, si fanno concorrenza sul prezzo, ma non possono vendere oltre la capacità dei loro posti.
di Bertrand presuppone che ogni impresa possa soddisfare tutta la domanda di mercato al prezzo più basso. Ciò non è realistico: in alcuni mercati le imprese possono produrre quantità virtualmente illimitate, ma in tanti altri esistono limiti alla capacità produttiva. In presenza di tali vincoli, se un’impresa abbassa il prezzo, non può comunque accaparrarsi l’intero mercato. Questo riduce l’incentivo a farsi la guerra sui prezzi, poiché i benefici di un prezzo più basso sono limitati dalla capacità disponibile. Di conseguenza, in equilibrio le imprese mantengono prezzi superiori al costo marginale, ottenendo profitti positivi. L’esito di equilibrio si avvicina allora a quello del modello di Cournot.
Per fare un esempio, supponiamo ancora che la domanda di mercato sia $Q=5000-1000P$ e che ciascuna impresa possa produrre, ad un costo marginale $MC=2$, una qualunque quantità che non sia maggiore di $800$ unità. È facile vedere che, in questo contesto, fissare prezzi uguali al costo marginale non costituisce un equilibrio di Nash. Consideriamo l’impresa 1. Se questa prendesse per dato che l’impresa 2 sta scegliendo $P_2=2$, la sua risposta ottima non sarebbe $P_1=2$. Annunciando un prezzo più alto, infatti, per esempio $P_1=3$, una quota di mercato sarebbe comunque sua. L’impresa 2 venderebbe la sua capacità produttiva ($800$ unità) al prezzo $P_2=2$, lasciando una domanda residuale, ovvero $Q=(5000-1000P_1)-800$, all’impresa 1. Anche l’impresa 1 riuscirebbe quindi a vendere la sua intera capacità produttiva, ottenendo un profitto pari a $(3-2)\times 800=800$.
Qual è allora l’equilibrio in questo caso? Entrambe le imprese scelgono il prezzo che consente al mercato di assorbire la loro capacità complessiva. Dato che questa è $800+800=1600$ unità di output, il prezzo che entrambe sceglieranno in equilibrio è $P_1=P_2=3.4$, dato che $1600=5000-1000\times3.4$. Ciascuna impresa ottiene quindi un profitto pari a $(3.4-2)\times800=1120$. Nessuna impresa vorrà fissare un prezzo più basso, dato che continuerebbe comunque a vendere $800$ unità e non di più ma, appunto, ad un prezzo più basso. E non vorrà nemmeno fissare un prezzo più alto. Per capire perché, supponiamo che l’impresa 1 fissi un prezzo pari a $3.4+\varepsilon$. Dato che questo prezzo è più alto di quello ($P_2=3.4$) fissato dall’impresa 2, i consumatori acquisteranno prima da quest’ultima, che venderà la sua intera capacità. Questo lascia all’impresa 1 la domanda residuale $Q=(5000-1000P_1)-800$, quindi il profitto dall’impresa 1 sarà
\(\begin{gathered} (3.4+\varepsilon-2) \times \big[ 5000-1000(3.4+\varepsilon)-800 \big] \end{gathered}\)
Ma questa è una funzione decrescente di $\varepsilon$!
Beni non omogenei
Un altro fattore
 Pur essendo prodotti simili, i panini di McDonald’s e Burger King sono diversi per metodo di preparazione, gusto e brand: i consumatori non li considerano omogenei.
che limita la concorrenza sul prezzo è la differenziazione del prodotto. Se i beni prodotti dalle imprese non sono perfetti sostituti per i consumatori, una riduzione del prezzo da parte di un’impresa non comporta automaticamente la perdita totale della domanda da parte dei concorrenti. Ogni impresa mantiene così un certo potere di mercato e riesce a ottenere profitti positivi. Vedremo adesso un semplice esempio in cui la concorrenza sui prezzi con beni differenziati porta a un equilibrio in cui il prezzo è maggiore del costo marginale.
Pur essendo prodotti simili, i panini di McDonald’s e Burger King sono diversi per metodo di preparazione, gusto e brand: i consumatori non li considerano omogenei.
che limita la concorrenza sul prezzo è la differenziazione del prodotto. Se i beni prodotti dalle imprese non sono perfetti sostituti per i consumatori, una riduzione del prezzo da parte di un’impresa non comporta automaticamente la perdita totale della domanda da parte dei concorrenti. Ogni impresa mantiene così un certo potere di mercato e riesce a ottenere profitti positivi. Vedremo adesso un semplice esempio in cui la concorrenza sui prezzi con beni differenziati porta a un equilibrio in cui il prezzo è maggiore del costo marginale.
Supponiamo che i beni prodotti dalle imprese 1 e 2 siano sostituti, ma non omogenei. Per riflettere questa ipotesi, assumeremo che la funzioni di domanda di mercato per i beni prodotti dalle imprese 1 e 2 siano rispettivamente
\(\begin{gathered} Q_1=5000-2000P_1+1000P_2 \\ Q_2=5000-2000P_2+1000P_1 \end{gathered}\)
dove $P_1$ e $P_2$ sono i prezzi scelti dalle due imprese. Le due imprese hanno costi marginali costanti e uguali: $MC_1=MC_2=2$.
Per calcolare l’equilibrio di Nash, scriviamo i profitti delle due imprese
\(\begin{gathered} \Pi_1=(P_1-2)(5000-2000P_1+1000P_2) \\ \Pi_2=(P_2-2)(5000-2000P_2+1000P_1) \end{gathered}\)
e massimizziamo il primo rispetto a $P_1$ e il secondo rispetto a $P_2$, ottenendo
\(\begin{gathered} 5000-4000P_1+1000P_2+4000=0 \\ 5000-4000P_2+1000P_1+4000=0 \end{gathered}\)
Le funzioni di risposta ottima sono quindi
\(\begin{gathered} BR_1: \quad P_1=(9+P_2)/4 \\ BR_2: \quad P_2=(9+P_1)/4 \end{gathered}\)
Risolvendo il sistema otteniamo l’equilibrio di Nash:
\(\begin{gathered} P_1=3 \qquad P_2=3 \end{gathered}\)
In equilibrio, i profitti delle due imprese sono quindi positivi:
\(\begin{gathered} \Pi_1=\Pi_2=(3-2)(5000-2000\times 3+1000\times 3)=2000 \end{gathered}\)
Collusione tacita
Infine,
 Nel 2015–2016 TIM, Vodafone e Wind Tre passarono dalla fatturazione mensile a quella a 28 giorni, portando da 12 a 13 le bollette in un anno (+8.6% di ricavi). Nel 2018, obbligate a tornare alla fatturazione mensile, aumentarono i canoni mensili dello stesso 8.6% in modo quasi identico. L’AGCM interpretò questo comportamento parallelo come collusione tacita e, nel 2019, multò le tre imprese per 228 milioni di euro.
anche in presenza di beni omogenei e assenza di vincoli di capacità, il paradosso di Bertrand può essere superato se le imprese interagiscono ripetutamente nel tempo. Nei giochi a più stadi, di cui non parliamo in queste note, le imprese non prendono decisioni isolate, ma considerano anche le ripercussioni future delle loro azioni.
Nel 2015–2016 TIM, Vodafone e Wind Tre passarono dalla fatturazione mensile a quella a 28 giorni, portando da 12 a 13 le bollette in un anno (+8.6% di ricavi). Nel 2018, obbligate a tornare alla fatturazione mensile, aumentarono i canoni mensili dello stesso 8.6% in modo quasi identico. L’AGCM interpretò questo comportamento parallelo come collusione tacita e, nel 2019, multò le tre imprese per 228 milioni di euro.
anche in presenza di beni omogenei e assenza di vincoli di capacità, il paradosso di Bertrand può essere superato se le imprese interagiscono ripetutamente nel tempo. Nei giochi a più stadi, di cui non parliamo in queste note, le imprese non prendono decisioni isolate, ma considerano anche le ripercussioni future delle loro azioni.
Se un’impresa abbassa il prezzo per guadagnare quote di mercato nel breve periodo, sa che ciò potrebbe innescare una reazione immediata da parte delle altre, con una guerra di prezzi che ridurrebbe i profitti di tutti. Ipotizzando che le imprese diano sufficiente importanza ai loro profitti futuri, in equilibrio (del gioco a più stadi) possono adottare strategie di collusione tacita, mantenendo prezzi alti ed evitando deviazioni che comprometterebbero guadagni futuri. Non è necessario un accordo esplicito: è sufficiente un’intesa implicita, sostenuta dall’osservazione reciproca e dalla possibilità di ritorsioni.