8.2 Correzione delle esternalità
Nella sezione precedente abbiamo visto che il problema delle esternalità nasce perché i soggetti danneggiati o beneficiati non sono partecipano alla contrattazione. Gli esempi di Alice, che sceglie la plastica generando un danno ambientale superiore al suo guadagno privato, e di Bruno, che rinuncia a installare un alveare pur producendo benefici per i vicini agricoltori, mostrano bene questo meccanismo: senza coinvolgere tutti gli interessati, il mercato conduce a scelte inefficienti.
Teorema di Coase
E se invece tutte le parti potessero facilmente partecipare alle trattative? Il teorema di Coase afferma
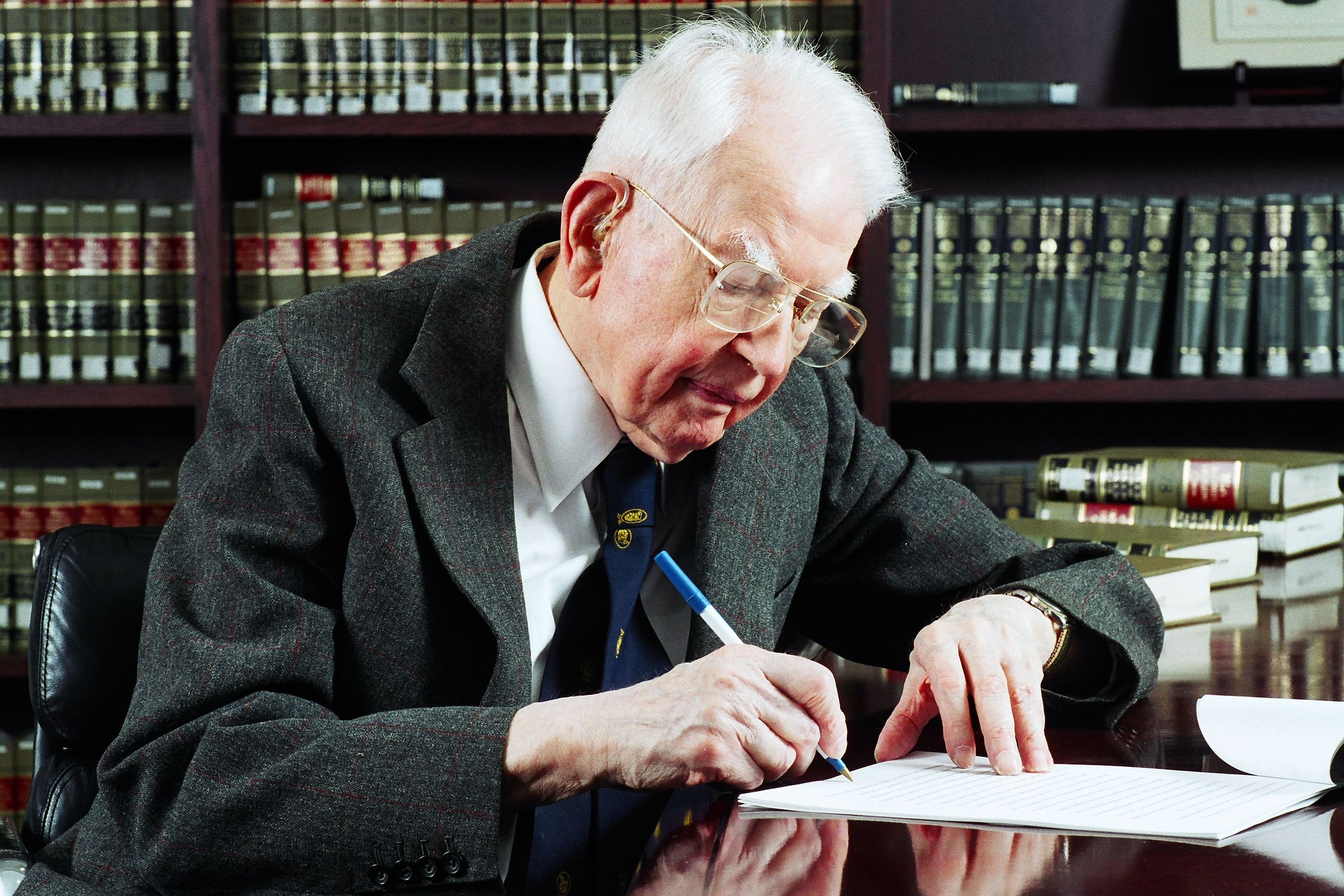 Ronald Coase
Ronald Coase
(premio Nobel per l’economia 1991)
che, se i diritti di proprietà sono ben definiti e i costi di transazione sono nulli, le parti contratteranno tra loro fino a raggiungere l’allocazione efficiente. L’intuizione è che il diritto — ad esempio a comprare plastica oppure a installare un alveare — finisce per essere detenuto da chi è disposto a pagare di più per averlo. Se chi detiene inizialmente il diritto gli attribuisce un valore basso, sarà incentivato a cederlo in cambio di un compenso; se invece lo considera prezioso, sarà disposto a pagare per mantenerlo. In questo modo, attraverso la contrattazione, l’esito finale coincide con quello socialmente efficiente.
Applichiamo il principio ai nostri esempi. Se il diritto è di Alice (può comprare plastica), i cittadini potrebbero offrirle un compenso perché scelga il vetro: lo farebbero ogni volta che il danno ambientale supera il beneficio privato di Alice. Se il diritto è dei cittadini (non si può comprare plastica senza essere autorizzati da loro), allora è Alice a poter proporre un pagamento per ottenere l’autorizzazione: ma lo farà solo se il suo beneficio supera il danno. In entrambi gli scenari, la contrattazione conduce alla stessa quantità efficiente. Lo stesso vale per Bruno e l’alveare: se il diritto di decidere spetta a lui, gli agricoltori possono compensarlo per indurlo a investire; se il diritto è dei vicini, sarà Bruno a proporre un accordo solo se l’alveare genera un beneficio sociale superiore al costo. Ancora una volta, l’esito efficiente viene raggiunto, anche se la distribuzione del surplus cambia a seconda di chi detiene i diritti iniziali.
Il teorema di Coase si basa su ipotesi forti: diritti di proprietà ben definiti e costi di transazione nulli. In pratica, queste condizioni si realizzano raramente: ad esempio quando le parti coinvolte sono poche e facilmente identificabili, quando l’informazione su danni e benefici è chiara, e quando i costi legali o di coordinamento tra le parti sono trascurabili. Nella maggior parte dei casi reali, tali circostanze non si verificano, e perciò la soluzione coasiana resta più che altro un benchmark teorico: dimostra che, in linea di principio, le esternalità possono essere risolte dal mercato stesso. Ma nella pratica, proprio perché queste condizioni raramente si verificano, è necessario ricorrere a strumenti di intervento pubblico.
Interventi statali
Quando il mercato produce troppo di un bene che genera un danno esterno, occorre ridurne la quantità. Quando produce troppo poco di un bene che genera un beneficio esterno, occorre incentivarlo. Il compito dello Stato è far sì che chi genera un costo o un beneficio esterno internalizzi l’esternalità, cioè la tenga in conto nelle proprie decisioni.
Come può lo Stato fare questo? Nel caso delle esternalità negative, come nel mercato delle bottiglie di plastica illustrato nella Figura 8.1, lo strumento tipico Sempre in The Economics of Welfare, Pigou introdusse l’idea di correggere le esternalità con imposte o sussidi. Strumenti moderni come la carbon tax o la plastic tax discendono direttamente da questa intuizione. è la tassa pigouviana (dal nome di Pigou, lo stesso della discriminazione di prezzo): un’accisa di aliquota pari al costo marginale esterno ($MEC$) calcolato in corrispondenza della quantità Diversi paesi hanno introdotto imposte specifiche su beni inquinanti. L’Italia, ad esempio, ha approvato una plastic tax di $0.45$ euro per kg di plastica monouso con la Legge di Bilancio 2020. socialmente efficiente. Se il $MEC$ è costante, come nell’esempio in cui ogni fardello di plastica genera un danno di $2$ euro, basta fissare una tassa di $2$ euro a fardello: la quantità di equilibrio di mercato cambia da $Q=5$ a $Q=4$, che coincide con l’ottimo sociale. Se il $MEC$ cresce con la quantità — ad esempio $MEC(Q)=Q/2$ — la logica non cambia: la tassa pigouviana è sempre pari al valore del $MEC$ valutato alla quantità efficiente. Nel nostro esempio, la quantità ottimale è $Q=4$ e quindi la tassa pigouviana è $T=MEC(4)=2$.
Specularmente, nel caso delle esternalità positive Politiche di questo tipo sono molto comuni: la Politica Agricola Comune (PAC), ad esempio, prevede programmi di sostegno specifici per l’apicoltura. lo strumento naturale è il sussidio. Nel mercato del miele della Figura 8.2, la quantità scambiata senza interventi ($Q=5$) è inferiore a quella ottimale ($Q=6.5$). Un trasferimento unitario pari al beneficio marginale esterno ($MEB$) — in questo caso 3 euro per chilo — incentiva l’apicoltore a produrre di più, spostando l’equilibrio sulla quantità socialmente efficiente.
Tasse e sussidi non sono però gli unici strumenti possibili. Un approccio alternativo è la regolazione diretta, con cui lo Stato impone limiti o standard vincolanti: può fissare un tetto massimo di produzione, vietare alcuni beni (come i sacchetti di plastica monouso) oppure imporre tecnologie meno inquinanti. Un altro strumento è rappresentato dai permessi negoziabili (cap-and-trade). In questo caso, lo Stato stabilisce la quantità totale ammissibile, emette un numero corrispondente di permessi e consente agli agenti economici di scambiarseli. Nel nostro esempio, limitare a 4 milioni i fardelli di plastica significa che il mercato, acquistando e vendendo permessi, troverà un prezzo tale da indurre le imprese a produrre complessivamente proprio $Q=4$.